Forni crematori in Italia: Padova
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli oratori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
 c/o Cimitero Maggiore Via del Cimitero 10 35136 Padova
c/o Cimitero Maggiore Via del Cimitero 10 35136 Padova
Aps Holding s.p.a.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova
Via Salboro 22/b - 35124 Padova
Tel: +390495660111 - Fax +390495660112
email: info@apsholding.it
PEC: apsholding@legalmail.it
Cod. Fisc./P.IVA 03860240286 - REA PD: 342892 Cap. sociale i.v. euro 32.308.316,00
Orari
L’accoglienza dei servizi funebri, destinati alla cremazione, è possibile nei seguenti giorni:
da Lunedì a Venerdì 07,15 – 18,00
Sabato e prefestivi 07,15 – 14,00
TARIFFE CREMAZIONE
| Defunti residenti | € 240,00 |
| Defunti residenti minori di 10 anni | € 120,00 |
| Salme da operazioni straordinarie | € 360,00 |
| Defunti non residenti | € 511,00 |
| Resti mortali | € 180,00 |
| Resti mortali da operazioni straordinarie | € 360,00 |
| Resti mortali provenienti da altro Comune | € 409,00 |
| Parti anatomiche riconoscibili | € 340,00 |
| Feti e prodotti del concepimento | € 150,00 |
| Cremazione ed esumazione ordinaria (senza rimborso in caso di rinuncia alla cremazione) | € 230,00 |
| Dispersione all’interno del cimitero | € 110,00 |
clic qui per tornare all'elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall'Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).
Cimiteri d'Italia: la Sicilia
La più estesa delle nostre isole offre anche un gran numero di preziose testimonianze della tradizione funeraria locale e della storia della nostra Patria, le visitiamo con questa carrellata tra i cimiteri più importanti di Sicilia.
Cimitero monumentale degli Angeli
 Il cimitero monumentale degli Angeli o cimitero degli Angeli è il cimitero di Caltanissetta. Fu aperto nel 1878 nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria degli Angeli e del castello di Pietrarossa.
Il cimitero monumentale degli Angeli o cimitero degli Angeli è il cimitero di Caltanissetta. Fu aperto nel 1878 nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria degli Angeli e del castello di Pietrarossa.
La costruzione del cimitero monumentale di Caltanissetta fu deliberata dal consiglio comunale il 23 marzo 1878 con uno stanziamento di 126.000 lire dell'epoca. I lavori iniziarono lo stesso anno seguendo, così, una tradizione iniziata in altre parti d'Italia con Napoleone.
La delibera faceva seguito ad un'accesa discussione svoltasi nei cinque anni precedenti; tra i siti valutati vi erano un terreno nella zona dell'abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver avuto nella scelta del sito anche il fatto che il convento dei frati minori osservanti fosse stato adibito dal 1867 come lazzaretto per i malati delle frequenti epidemie di colera dell'epoca.
Il progetto fu dell'ingegnere Alfonso Barbera, lo stesso che aveva progettato la facciata del Comune e del Teatro Margherita.
Il cimitero degli Angeli è posto sopra una collina argillosa che domina la valle dell'Imera meridionale, nelle vicinanze del castello di Pietrarossa, ivi edificato in epoca bizantina, per un controllo strategico della valle.
Il cimitero permette una visione panoramica per la sua posizione sopraelevata di paesaggi del centro Sicilia meridionale ricchi di colline argillose e calanchi. Lungo l'asse est-ovest si osservano la Serra della Difesa con il suo Vallone della Difesa e Iuculia ad est si osserva il monte di Sabucina con il suo sito archeologico. In direzione nord si osservano il monte San Giuliano con il suo monumento al Redentore e la collina di Sant'Anna con l'antenna RAI, colline queste che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero si sviluppa, lungo una forte pendenza lungo l'asse sud, con viali interni sinuosi cui si affacciano cappelle gentilizie tra le quali per il loro valore architettonico e artistico si distinguono quelle delle famiglie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera: tra di esse, le più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calafati, Difìglia, Falduzza, Giarrizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e Testasecca.
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella è ricavata da un anfratto della rocca di Pietrarossa su cui si ergono sovrastando il cimitero i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un ambiente già abitato in epoca bizantina del castello.
Il cimitero degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta, l'altro è il piccolo "cimitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo creato a ricordo di una disgrazia mineraria del 12 novembre 1881 dove persero la vita 19 carusi di cui nove rimasti senza nome.
Cimitero monumentale di Caltagirone
 Il cimitero di Caltagirone è un importante cimitero monumentale siciliano, realizzato nella seconda metà del 1800. Si trova nella via Nicastro, a tre chilometri dal centro abitato. Viene chiamato cimitero del Paradiso, dal nome della contrada omonima in cui sorge. Fu dichiarato monumento nazionale nel 1931.
Il cimitero di Caltagirone è un importante cimitero monumentale siciliano, realizzato nella seconda metà del 1800. Si trova nella via Nicastro, a tre chilometri dal centro abitato. Viene chiamato cimitero del Paradiso, dal nome della contrada omonima in cui sorge. Fu dichiarato monumento nazionale nel 1931.
Nel 1852, don Pasquale Gravina, un nobile calatino, invitò l'architetto Giovan Battista Filippo Basile a realizzare un progetto per il camposanto di Caltagirone, ma il piano realizzato da costui non ebbe seguito, perciò nel 1866 la progettazione venne affidata all'architetto Giovan Battista Nicastro che due anni prima aveva realizzato il palazzo di Città.
Nel 1875 i lavori erano già in stadio avanzato e si presentava come è nei tempi odierni ad eccezione della chiesa centrale. Il complesso, realizzato in stile gotico-siciliano, ha pianta quadrata con croce greca costituita da 170 arcate, che vanno a formare i portici che costituiscono le quattro vie principali.
L'architetto Nicastro utilizzò materiali facilmente reperibili in Sicilia, quali la pietra bianca del ragusano, la pietra lavica e la terracotta. L'area del cimitero, inizialmente di ventimila metri quadrati, è stata in seguito notevolmente ampliata.
Il cimitero è ricco di pitture, sculture, fregi e capitelli, che lo rendono monumento nazionale e meta di visitatori. Lungo l'asse nord-sud vi sono gli elementi più importanti: il portico d'ingresso, il Famedio, l'Ossario, interrato e posto al centro della croce greca nella piazza ottagonale.
Cimitero monumentale di Catania
Il cimitero monumentale di Catania sorge in via Acquicella, nell'omonimo quartiere a nord della Zia Lisa, fu aperto nel 1866, su di un terreno che in precedenza apparteneva alle monache di Santa Chiara.
Dopo l’editto di Saint Cloud e dopo il Congresso di Vienna il Regno delle Due Sicilie legiferò nel 1817 sulla falsariga del famoso editto francese. In questo periodo il duca di Sammartino propose al consiglio provinciale di realizzare un cimitero per ottemperare al termine ultimo del 1º gennaio 1831 fissato dal decreto reale del 12 dicembre 1828, il quale intimava che entro tale data fossero ultimati tutti i cimiteri del regno.
Nel 1835 nella zona della Plaia si iniziò la costruzione di un camposanto, per far fronte alla grave epidemia di colera del 1837, l'incarico fu affidato a Sebastiano Ittar, ma il luogo scelto non era adatto in quanto il terreno era fortemente sabbioso e i cani riuscivano a dissotterrare i corpi, quindi non era conforme alle direttive vigenti in materia.
A marzo del 1856, l'ingegnere Eligio Sciuto riceve l'incarico per redigere il progetto del cimitero che sarebbe sorto su di un terreno comunale, denominato "Fondo del Crocifisso", conforme ai regolamenti del regno, ma gli eventi politici accaduti nel 1860, quali lo sbarco a Marsala dei Garibaldini, la caduta dei Borboni e la costituzione del Regno d'Italia, ostacolano la prosecuzione del progetto.
Le leggi Siccardi del 1866 e del 1867 abolirono le corporazioni religiose e ne confiscarono i beni, tra i quali la tenuta di Santa Chiara, ove vi era un vigneto. Il terreno, ritenuto adatto alla costruzione del camposanto, sia per le caratteristiche tecniche, per la sua posizione geografica, si trovava in contrada Acquicella. All'epoca il centro abitato era distante circa un chilometro dal luogo dove sarebbe sorto il cimitero, inoltre la sua posizione era favorevole ai venti dominanti, condizione necessaria per rispettare appieno la legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865 e il successivo regolamento dell'8 giugno di quello stesso anno.
Il cimitero aprì nel 1866, circoscritto da una recinzione in legno: ora non restava che provvedere al lato artistico del progetto, l'incarico di trovare un progettista fu dato all'ingegnere comunale Ignazio Landolina, che contattò dapprima il professor Mariano Falcini di Firenze, ma il suo progetto fu accantonato. In seguito la scelta cadde su Leone Savoja, che si era brillantemente occupato del cimitero monumentale di Messina; il 15 ottobre del 1871 fu emanata la delibera che rese Savoja ingegnere specialista per la sistemazione del camposanto.
Furono costruiti due ingressi, quello principale, costituito da un corpo di fabbrica in stile neoclassico a tre fornici chiusi da cancelli e quello secondario che dà accesso diretto al viale delle Confraternite. Il terzo ingresso in Via Acquicella, fu realizzato negli anni sessanta del Novecento a seguito dell'ampliamento del camposanto.
Cimitero militare germanico di Motta Sant'Anastasia
 Il cimitero militare germanico è situato a Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania. Tra gli altri, vi è sepolto Luz Long campione di atletica (medaglia d'argento in salto in lungo alle olimpiadi di Berlino nel 1936).
Il cimitero militare germanico è situato a Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania. Tra gli altri, vi è sepolto Luz Long campione di atletica (medaglia d'argento in salto in lungo alle olimpiadi di Berlino nel 1936).
Nel 1954 venne stipulato un accordo tra il governo tedesco e quello italiano in base al quale venne scelta un'area in cui seppellire tutti i caduti tedeschi morti durante la seconda guerra mondiale in Sicilia. Il cimitero venne inaugurato il 25 settembre 1965. Dopo importanti lavori di ristrutturazione è stato riaperto ufficialmente il 29 aprile 2011.
Il cimitero è collocato ai margini della strada che conduce al paese di Motta Sant'Anastasia.
Il cimitero militare aveva una struttura che, in origine, era rettangolare e misurava 43x32 metri. La struttura ha subìto negli anni dei mutamenti ed ha assunto una forma che possiamo definire "semi rettangolare". L'area sepolcrale è collocata nei sotterranei non accessibili perché murati; qui vi sono sepolti 4.561 caduti tedeschi nella seconda guerra mondiale. La raccolta dei corpi è stata effettuata dal Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge che si occupa anche della manutenzione dell'area.
L'ingresso è costituito da un atrio lastricato in travertino. Qui è collocata una stele che recita:
|
«IN DIESER KRIEGSGRÄBERSTÄTTE RUHEN 4561 DEUTSCHE GEFALLENE |
Una volta entrati, attraverso una scalinata ci si trova in un cortile denominato Kameradengrab. In questa area è presente una lapide contenente i nomi di 31 soldati che qui sono sepolti. In altre otto lastre di pietra sono ricordati i nomi di 128 soldati tedeschi caduti durante le operazioni in Sicilia negli anni 1941 - 1943. Al centro del cortile è posta una statua in bronzo raffigurante un uomo morente, fortemente espressiva e di ottima fattura. Da questo cortile si può accedere ad altri quattro cortili dove su lastre di ardesia sono ricordati i nomi dei caduti ospitati nei sotterranei.
I quattro cortili ospitano le tombe dei caduti suddivisi per province.
Cimitero monumentale di Paternò
Il cimitero monumentale di Paternò sorge in via degli Svevi nella parte meridionale dello storico colle di origine vulcanica ("Collina storica"), situato nella zona occidentale del territorio di Paternò, in provincia di Catania.
Le leggi del 1866 di confisca dei beni ecclesiastici portarono alla soppressione del convento dei cappuccini situato nel colle paternese. Il terreno ad esso adiacente venne requisito per la costruzione del cimitero, che venne inaugurato nel 1887. Parte dei locali furono adibiti a uffici comunali per i servizi cimiteriali e deposito delle salme.
Dell'ex convento oggi rimane soltanto la cappella dei frati, ossia, l’attuale chiesa di Santa Maria delle Grazie, attigua all'ingresso principale del cimitero. Sul lato sinistro dell'ingresso principale del cimitero, vi è incisa una lapide che ricorda la sepoltura di militari ungheresi della prima guerra mondiale morti durante la loro prigionia a Paternò.
Il cimitero è stato costruito secondo alcuni storici su quella che era la città greco-romana, o per lo più in quel sito. I vialetti le scalinate e le stradine interne, erano le vecchie strade che soprattutto in epoca greco-romana solcavano il luogo.
La maggior parte delle Cappelle gentilizie e confraternali sono in stile liberty, e rappresentano delle vere e proprie opere d'arte.
Le tombe-mausoleo per gran parte sono costruite in marmo, ornate da statue di Madonne, Gesù angeli, putti santi vari e decorazioni varie, busti marmorei e lapidi elaborate.
La superficie si estende per buona parte del lato posteriore della "Collina storica" è confina con la chiesa di Santa Maria dell'Alto. La parte meridionale si affaccia sulle campagne di contrada San Marco da cui si gode un magnifico panorama sulla valle del Simeto. Questa ubicazione rende il luogo molto suggestivo e quasi unico nel suo genere, per questo è considerato tuttora uno dei cimiteri più romantici e incantevoli d'Italia e nella parte superiore è confinante con la chiesa di Santa Maria dell'Alto.
Cimitero degli inglesi di Messina
 Il cimitero degli inglesi sorgeva inizialmente nella zona di San Raineri nel sito “La Spina”, presso la zona Falcata della città di Messina. Fu concesso dal re Ferdinando IV ai marinai inglesi, giunti in Sicilia in aiuto dei Borboni, che si opponevano ai tentavi di conquista dei francesi guidati da Napoleone.
Il cimitero degli inglesi sorgeva inizialmente nella zona di San Raineri nel sito “La Spina”, presso la zona Falcata della città di Messina. Fu concesso dal re Ferdinando IV ai marinai inglesi, giunti in Sicilia in aiuto dei Borboni, che si opponevano ai tentavi di conquista dei francesi guidati da Napoleone.
Dopo le guerre napoleoniche, il camposanto cominciò a ospitare civili inglesi con le loro famiglie stabilitesi a partire dal 1815. Ad essi si aggiunsero famiglie di mercanti tedeschi (Grill, Aders, Falkenburg, Jaeger), svizzeri, danesi, greci e russi, che risiederono a Messina almeno fino al terremoto del 1908.
Il 5 aprile 1925, il cimitero fu visitato dal re Giorgio V e dalla regina Mary, accompagnati dai Principi Giorgio e Maria Vittoria.
Nel 1942 fu trasferito all'interno del Gran Camposanto, quando il vecchio sito fu utilizzato per scopi militari e durante questa operazione vennero spostate 280 tombe.
Lapide che commemora la visita del re Giorgio V del Regno Unito
Il cimitero nell'Ottocento era curato dalla comunità inglese.
Il cimitero inglese si trova salendo dalla via San Cosimo (adiacente al Gran Camposanto) e dalla stessa entrata si accede verso la zona sud del cimitero monumentale di Messina.
Nel cimitero inglese si possono ammirare i monumenti funerari di ricchissimi esponenti della Messina dell'Ottocento, tra i più importanti Federico Grill, banchiere molto popolare e amato dal popolo messinese, James Thomas Eaton, proprietario delle filande del villaggio di Gazzi, Giovanni Walser, banchiere e filantropo.
Cimitero monumentale di Messina
 Il cimitero monumentale di Messina, detto anche Gran camposanto, è uno dei più importanti cimiteri monumentali d'Europa ed è assieme a quello di Staglieno il cimitero monumentale più artistico d'Italia. Al suo interno è presente la gran parte della statuaria e dell'architettura del neoclassicismo messinese. Parte del gran camposanto è il cimitero inglese.
Il cimitero monumentale di Messina, detto anche Gran camposanto, è uno dei più importanti cimiteri monumentali d'Europa ed è assieme a quello di Staglieno il cimitero monumentale più artistico d'Italia. Al suo interno è presente la gran parte della statuaria e dell'architettura del neoclassicismo messinese. Parte del gran camposanto è il cimitero inglese.
Sorge nei pressi della zona centrale della città, di fronte alla villa Dante sulla via Catania ma si estende per ben ventidue ettari.
Nel 1854, nel periodo in cui una gravissima epidemia di colera flagellava Messina e altre parti della Sicilia, venne emanato il bando di concorso affinché si edificasse un camposanto per la città.
Il bando fu aperto a tutti i progettisti del Regno delle due Sicilie e vide vincitore l'architetto messinese Leone Savoja ma passarono ben sette anni prima che la giunta municipale deliberasse l'esecuzione dell'opera, anche se i lavori più importanti iniziarono nel 1865. Fu inaugurato poi nel 1872.
L'architettura liberty, neogotica e neoclassica del cimitero è arricchita dalla presenza di una lussureggiante vegetazione e dai curatissimi giardini che inframezzano gli spazi sepolcrali. Il cimitero fu concepito sin dalle origini come un vero e proprio parco urbano e può essere definito "la galleria d'arte moderna e contemporanea all'aperto" della città di Messina. Sono tante, infatti, le presenze di artisti locali e non, sia dell'Ottocento che del Novecento, propugnatori in città delle varie correnti artistiche provenienti dal continente, in particolare dalla Francia (purismo, verismo, neobarocchismo, liberty, razionalismo).
Dalla Porta Maggiore del Gran camposanto di Messina, si può notare un suggestivo effetto scenografico, rappresentato da un grande piazzale contornato da fiori posti con un ordine accurato che va a comporre un disegno che raffigura lo stemma della città di Messina con i colori simbolo della città, il giallo e rosso su campo bianco e, in alto, la dicitura Orate Pro Defunctis.
Lateralmente alla Porta Maggiore si snodano i due viali che percorrono la galleria monumentale, che insieme al famedio ospita i sepolcri dei messinesi illustri. Il viale sinistro, che termina nei pressi del cimitero degli inglesi, ospita perlopiù le tombe di politici, patrioti e militari. Nel viale destro, oltre le tombe di letterati e giuristi, da menzionare sono le tombe di Giacomo Natoli, Tommaso Cannizzaro e Gaetano Martino.
Il Cenobio ospita numerosi monumenti sepolcrali di ragguardevole valore artistico. Al piano superiore si trova un grande salone ed una passerella con delle finestrelle che danno sulla chiesa e la scalinata. Conosciuto anche con i nomi di cappella gotica o conventino, la sua progettazione è attribuita a Giacomo Fiore (1808-1893).
Fino al 1908, la cappella fu adibita allo svolgimento di funzioni religiose, fu la sede degli uffici del Gran camposanto e ospitò l'alloggio del cappellano-direttore e del suo coadiutore. Il sisma del 1908 provocò danni agli elementi decorativi senza comprometterne gli elementi strutturali. All'inizio degli anni trenta fu oggetto di un intervento di restauro, nel corso del quale fu anche notevolmente modificata la distribuzione interna. I lavori terminarono nel 1932 e nell'ottobre dello stesso anno fu inaugurato.
I lavori per la costruzione del famedio cominciarono nel 1865 su progetto di Leone Savoja. L'opera fu inaugurata il 27 marzo 1872 e vennero trasferite delle spoglie di Giuseppe La Farina da Torino che furono tumulate nella tomba scolpita da Gregorio Zappalà.
Il famedio è una sorta di mausoleo ed è attraversato da una galleria sotterranea, rassomigliante a delle catacombe, per la tumulazione dei morti. La facciata è caratterizzata da un elegante colonnato ma causa la prematura morte del Savoja, la parte monumentale più bella non fu costruita.
È stato gravemente danneggiato dal terremoto del 1908 che provocò il crollo di parti del complesso e in particolare della copertura, che non fu più ricostruita.
Cimitero acattolico di Siracusa
 Il cimitero acattolico di Siracusa si trova a Siracusa, nel parco di Villa Landolina che fa oggi parte del Museo archeologico Paolo Orsi.
Il cimitero acattolico di Siracusa si trova a Siracusa, nel parco di Villa Landolina che fa oggi parte del Museo archeologico Paolo Orsi.
Dal momento che le norme della Chiesa cattolica vietavano di seppellire in terra consacrata i non cattolici — tra cui i protestanti, gli ebrei e gli ortodossi — nonché i suicidi, questi, dopo morte, erano "espulsi" dalla comunità cristiana cittadina e inumati fuori dalle mura (o al margine estremo delle stesse).
La famiglia Landolina diede la disponibilità alla realizzazione del "cimitero degli acattolici" nel proprio parco. Il cimitero è di piccole dimensioni e comprende dodici sepolture realizzate nel corso dell'Ottocento per alcuni stranieri di fede non cattolica morti a Siracusa.
Vi sono sepolti il poeta tedesco August von Platen ed alcuni marinai americani che parteciparono alla prima guerra barbaresca (1801-1805), la prima guerra combattuta dagli Stati Uniti d’America al di fuori del territorio americano. Essi sono Joseph Maxwell, Seth Cartee (Carter), William Tyler, James Deblois e George S. Hackey.
Syracuse War Cemetery
 Il Syracuse War Cemetery (Il cimitero di guerra di Siracusa), chiamato dai locali semplicemente "Cimitero inglese", è un cimitero di guerra britannico che si trova a Siracusa, in Via per Floridia 10, contrada Canalicchio, lungo la SS 124, nei pressi del Cimitero Comunale. Esso raccoglie le salme dei soldati del Commonwealth caduti in battaglia durante la Seconda guerra mondiale, in tutto il territorio della provincia.
Il Syracuse War Cemetery (Il cimitero di guerra di Siracusa), chiamato dai locali semplicemente "Cimitero inglese", è un cimitero di guerra britannico che si trova a Siracusa, in Via per Floridia 10, contrada Canalicchio, lungo la SS 124, nei pressi del Cimitero Comunale. Esso raccoglie le salme dei soldati del Commonwealth caduti in battaglia durante la Seconda guerra mondiale, in tutto il territorio della provincia.
Il cimitero di Siracusa è uno dei tre cimiteri di guerra del Commonwealth presenti in Sicilia. La sua ideazione e la scelta del luogo avvenne già nel 1943, durante la prima fase dello Sbarco in Sicilia, tuttavia, venne ufficialmente istituito, insieme ad altri 51 dislocati sull'intero suolo nazionale, nel 1953, a seguito dell'accordo stipulato a Roma il 27 agosto tra lo Stato italiano ed i seguenti stati: Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, India e Pakistan. Fino a quel periodo, infatti, le salme erano state ospitate nel vicino cimitero comunale di Siracusa.
La cura e la manutenzione sono affidate alla Commonwealth War Graves Commission, commissione appositamente creata, nel 1917 ad opera dei Paesi che appartengono al Commonwealth, proprio con lo scopo di curare e mantenere i luoghi di sepoltura ed i monumenti di guerra dei Caduti panbritannici, siti in ogni parte del mondo.
Nel 1955 fu visitato da Winston Churchill e nel 1990 dal Principe Edoardo, Duca di Kent, in visita ufficiale nella città aretusea.
Il cimitero di Siracusa è suddiviso in due file parallele di quattro settori e sul fondo campeggia una grande croce latina di marmo bianco; al suo interno vi sono quattro monumenti, uno recante l'iscrizione "ritenuto di essere seppellito in questo cimitero" ed altri tre, che ricordano uomini sepolti, in origine in altri luoghi, ma le cui tombe non furono trovate e che portano incisa la frase "La loro gloria non sarà mai cancellata".
Le lapidi, poste verticalmente, secondo la tipologia dei cimiteri anglosassoni, presentano un numero romano, una lettera maiuscola ed un numero che indicano rispettivamente, il settore, la fila e la tomba, oltre al nome, la data di morte, l'età, il simbolo della religione professata, il distintivo del corpo di appartenenza ed il grado del soldato.
Le sepolture sono 1.063, in massima parte di militari del secondo conflitto mondiale, soprattutto di caduti il 10 luglio 1943, quando ci fu lo sbarco in Sicilia. Molti soldati appartenevano alle truppe aviotrasportate e furono uccisi quando i venti deviarono i loro alianti o in mare o lontano dagli obiettivi. Tra gli altri caduti, ve n'è anche una di un caduto della Prima guerra mondiale, le cui spoglie provengono dal cimitero inglese di Marsala e quella di un marinaio della Royal Navy catturato a Malta e poi morto ad Augusta nel 1942. Oltre ai militari del Commonwealth (britannici, indiani, canadesi, neozelandesi e sudafricani) vi sono anche le salme di tre soldati greci, due olandesi e sei di nazionalità sconosciuta. Infine, sono sepolte anche le ceneri di alcune vedove di guerra inglesi, che avevano espressamente richiesto alla Commissione del Commonwealth per le sepolture di guerra di essere tumulate accanto ai mariti.
Sacrario di Pianto Romano
 Il sacrario di Pianto Romano è un monumento garibaldino nel territorio del comune di Calatafimi Segesta, in località Pianto Romano.
Il sacrario di Pianto Romano è un monumento garibaldino nel territorio del comune di Calatafimi Segesta, in località Pianto Romano.
L'appello iniziale per la costruzione di un monumento, che raccogliesse i resti dei caduti e ricordasse la battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860, fu lanciato il 9 settembre dello stesso anno da un comitato di abitanti del piccolo centro. Fu progettato nel 1885 da Ernesto Basile, ma fu solo il 15 maggio 1892 che il sindaco Salvatore Cabasino, alla presenza del generale Paolo D'Oncieu de la Bâtie rappresentante del re Umberto I, poté inaugurare il sacrario di Pianto Romano.
Il monumento sorge proprio nella sommità dell'altura che fu teatro della battaglia, a qualche chilometro dal centro abitato di Calatafimi, e ha la forma di un obelisco. Contiene un ossario dove sono custodite le spoglie dei caduti, garibaldini, picciotti e borbonici, e altri cimeli.
Nelle parole del progettista si doveva trattare di «… Poche masse, ma chiaramente apprezzabili anche da lungi; studiata così la linea di contorno dell'insieme in relazione cogli effetti prospettici e coi punti di vista dal basso: ricercata la finezza del sentimento delle linee generali e delle sagome. Tali i criteri da cui mi mossi e di cui avevo a pochi passi da Calatafimi splendidissimo esempio, il tempio di Segesta…», inoltre doveva essere completamente in «pietra calcare grigia del paese (Alcamo), materiale che si presta a una lavorazione accurata delle facce e degli spigoli…».
L'obelisco è decorato, così come previsto dal Basile, da due altorilievi in bronzo contenuti in due finestrature rettangolari, opera di Giovanni Battista Tassara (uno dei Mille), raffiguranti lo sbarco a Marsala e la battaglia di Calatafimi; i due rilievi furono inseriti a inaugurazione avvenuta. Oltre ai due altorilievi è presente anche una ghirlanda, sempre in bronzo, di palme e quercia.
Forni crematori in Italia: Piscina (TO)
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
Tel. (+39) 0121.329266
Fax. (+39) 0121.571439
E-Mail : info@hysteron.it
I prezzi fissati per il 2020 a Piscina stabiliscono un massimo di 511,60 euro iva esclusa per la cremazione di un corpo.
clic qui per tornare all'elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall'Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).
Forni crematori in Italia: Domicella (AV)
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
P.I. 07502531218 - Sede Legale: Via G. Porzio 4, 80143 Napoli - Sede Operativa: Via Cimitero 83020 Domicella (AV)
Tel. 081/8250771 - Cell. 333/4834201 - 324/8405553 - Fax 081/0106333 - email: domicellasrl@gmail.com
Indirizzo: Via Cimitero, Domicella AV
Orari: Chiude alle ore 21
Telefono: 333 483 4201
Il costo per la cremazione di un corpo a Avellino e provincia per il 2020 è di 511,60
clic qui per tornare all'elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall'Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).
Regione Piemonte si pronuncia sui trasferimenti a cassa aperta per i sospetti o conclamati Covid.
Forni crematori in Italia: Mappano (TO)
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli operatori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
Tempio di Mappano c/o Civico Cimitero
Via Argentera s.n., 10079 Mappano (To) – Italia
Tel: 011 9968 268
info@tempiocrematoriomappano.it
socremmappano@pec.it
TARIFFA PER LA CREMAZIONE € 545
Con decorrenza 1° settembre 2019, la tariffa ministeriale applicata a Mappano per la cremazione è di 545,00 euro (IVA al 22% compresa).
La tariffa di cremazione per i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione è di 436,00 euro (IVA al 22% compresa).
clic qui per tornare all'elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall'Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).
Indicazioni inerenti al settore funebre del nuovo DPCM “fase 2” in vigore dal 4 al 18 maggio 2020
Riportiamo qui a seguito gli estratti riferiti alle imprese funebri (e attività connesse) contenuti nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prima che venisse emessa la relativa comunicazione di CEI, Conferenza Episcopale Italiana.
ART 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Comma 1,
lettera i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi … di carattere religioso[1], … svolti in ogni luogo sia pubblico che privato…;
l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro[2].
Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque fino ad un massimo di quindici persone[3], con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto[4], indossando mascherine protettive e rispettando le misure di distanziamento sociale.
lettera cc) sono sospese le attività̀ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2[5];
Art. 2 - Misure per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Comma 8) La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fini al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Art. 10 - Disposizioni finali
Comma 1) le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 … e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 …
[1] Tutti gli eventi legati alle manifestazioni, santi patroni, raduni, etc etc .
[2] Le chiese hanno comunque la possibilità di rimanere aperte in rispetto delle condizioni di sicurezza.
[3] È consentita l’esecuzione del servizio funebre con la partecipazione di parenti di primo grado (figli e genitori) e quelli di secondo grado (fratelli, sorelle, nipoti e nonni) sempre nel rispetto delle distanze interpersonali.
[4] La funzione deve svolgersi preferibilmente e non obbligatoriamente all’aperto. Tale indicazione è valida soprattutto dove chiese e cappelle non possono garantire la necessaria distanza interpersonale.
[5] Allegato 2 Servizi per la persona: … Servizi di pompe funebri e attività connesse
clic qui per scaricare il PDF del DPCM in formato testo (più leggero)
Pandemia da coronavirus e doveri morali delle attività funebri
La recrudescenza della pandemia che registriamo in tutto il paese con punte di diffusione delle infezioni di 30/40.000 nuovi positivi al giorno ripropone la drammaticità della situazione con il moltiplicarsi dei decessi.
Registrare decessi giornalieri a causa del COVID-19 di 500, 600 per arrivare anche ad oltre 700 morti in un giorno significa, lo dobbiamo ben comprendere, un incremento della mortalità a livello nazionale di quasi il 50%, dai circa 1800 decessi giornalieri si passa ad oltre 2500.
Gli amici che operano nelle grandi città, Roma, Milano, Torino, Napoli e hinterland relativi vivono concretamente le difficoltà di dover garantire, da molti giorni, un numero di servizi funebri doppio rispetto alla normale mortalità registrata nel corso degli anni.
Abbiamo sottolineato più volte, in questa nostra rivista, gli effetti che ricadono, e dureranno nel tempo, sulle famiglie che sono private di un corretto e desiderato rito di commiato dai propri cari; però non si tratta solo di questo.
Il fatto di notare sempre più frequentemente accattivanti pubblicità di servizi funebri a tariffe irrisorie e leggere comunicazioni di questa natura anche su quella che viene considerata la “stampa seria”, i grandi giornali, sollecita una ribellione sempre più marcata perché tutti avvertiamo la carica truffaldina di questi annunci verso famiglie che vivono uno stato di particolare debolezza in concomitanza di un decesso.
Sono anni che sottolineiamo e combattiamo questi fenomeni perché siamo convinti e sicuri che scendere, in qualsiasi parte del nostro Paese, nord, sud, est, ovest, sotto la soglia di € 1800,00/2000,00 per un servizio funebre rappresenti un bluff ed una truffa vera e propria: o si usano queste proposte per attrarre la clientela nella convinzione che se ti faccio entrare in agenzia a 1500,00 ti farò uscire a 2500,00 o ancora di più, oppure eseguirò un servizio senza rispettare le norme e le regole truffando lo Stato.
Il diffondersi, quindi, di queste pubblicità oltre a sollecitare un senso di montante ribellione è causa di danni enormi per il settore e per la categoria intera: forse non si ha la piena consapevolezza che in una società sempre più dipendente dalla “comunicazione” questi messaggi faranno maturare progressivamente la convinzione generalizzata che il costo di un servizio non è quello cui fanno riferimento tutte le indagini sul settore condotte dagli Uffici dello Stato (Agenzia delle Entrate, Intendenza di Finanza, Studi di settore, prima, Indici Sintetici di Affidabilità, oggi…) ma quelli che questi operatori pubblicizzano. Con l’andare del tempo o imboccheremo la strada degli “smaltitori di rifiuti”, i cadaveri cioè che ci vengono affidati, o ricorreremo in modo generalizzato ad una crescente evasione od elusione delle norme e degli impegni fiscali. Sono percorsi che portano all’autodistruzione della categoria.
Non possiamo rimanere inerti, dobbiamo attivare tutti gli strumenti per garantire alle famiglie dignità dei servizi e rispetto per i loro defunti partendo proprio dal rispetto delle regole e, quindi, dal rispetto per i propri concorrenti riguadagnando un senso concreto della categoria, perché solo conquistando ed accrescendo la consapevolezza di essere categoria, e non operatori solitari, potremo guardare con fiducia al nostro futuro ed alla conquista di norme e regole capaci di favorire la nostra professionalità, sostenere la nostra crescita e garantire la nostra futura sicurezza.
Qualcosa concretamente abbiamo fatto stabilendo positivi rapporti con lo I.A.P., l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, che ha disposto la rimozione di cartelli pubblicitari non corretti in Toscana, grazie ai nostri Dirigenti, ma non basta, in attesa di disposizioni di legge più attente anche a questi comportamenti.
La Federazione dovrà diventare, anche su questi temi, un punto di riferimento per la tutela della correttezza operativa del settore. E la correttezza parte da una “onesta, veritiera e corretta informazione” nella speranza che anche gli organo dello Stato sviluppino una maggiore attenzione a questi aspetti.
Con questa riflessione si avvierà, sulla nostra rivista, HERMES funeraria, una rubrica specifica di informazione su questi temi.
Cristian Vergani
Segretario Nazionale Federcofit
Forni crematori in Italia: Treviso
Dopo aver parlato della cremazione e del suo sviluppo nel nostro Paese, e dopo avere pubblicato l’elenco dei crematori oggi in attività regione per regione, iniziamo a presentare su Hermes funeraria i singoli impianti con le informazioni essenziali ed utili per gli oratori funebri che debbano fare affidamento a queste strutture nel proprio territorio di intervento.
 C/o Cimitero di Santa Bona, via Giovanni Battista Riccioli, 31100 Treviso
C/o Cimitero di Santa Bona, via Giovanni Battista Riccioli, 31100 Treviso
Contarina S.p.A. - società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula
Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano | CF e P.Iva 02196020263 |
Telefono 0422/212791
Fax 0422/212796
Le tariffe per le cremazioni sono le seguenti:
| Cadavere di residente nel Comune | € 424,95 |
| Cadavere di non residente | € 546,95 |
| Ossa di singolo cadavere / resti mortali inconsunti | € 437,55 |
Gli importi si intendono IVA inclusa.
Per le tariffe relative ad altre tipologie di cremazioni è possibile contattare il numero 0422/212791.
Il pagamento va effettuato prima del ritiro delle ceneri. La ricevuta dell’avvenuto bonifico va inoltrata via fax al numero 0422/212796. In mancanza della documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di cremazione, non sarà possibile ritirare l’urna.
clic qui per tornare all'elenco completo dei crematori italiani
Tutti i prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione, e potrebbero quindi essere stati modificati dall'Operatore.
Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).
Cimiteri d'Italia: il Veneto - Verona, Vicenza e Padova
La ricca tradizione storica e culturale del Veneto si riflette anche nei suoi Cimiteri, di cui con questo articolo continuiamo la visita dopo la puntata veneziana.
Cimitero monumentale di Verona
 Il cimitero monumentale di Verona è il camposanto principale della città di Verona. È stato progettato dall'architetto Giuseppe Barbieri a partire dal 1828.
Il cimitero monumentale di Verona è il camposanto principale della città di Verona. È stato progettato dall'architetto Giuseppe Barbieri a partire dal 1828.
Nel 1806 fu esteso al Regno d’Italia l’editto napoleonico di Saint Cloud, che stabilì la collocazione dei cimiteri al di fuori delle mura cittadine. La città di Verona, di conseguenza, si trovò di fronte alla necessità di individuare un sito adeguato per il proprio camposanto: la ricerca richiese circa due decenni e nel 1826 fu acquisita allo scopo la vasta area del Campo Marzo, all’altezza di Porta Vittoria.
Prima di esso, i defunti venivano tumulati nelle varie chiese, principalmente nella chiesa di San Bernardino e nella chiesa della Santissima Trinità in Monte Oliveto.
Dopo la morte di Giuseppe Barbieri nel 1838, i lavori per il cimitero vennero sovrintesi dall’architetto Francesco Ronzani, che li concluse in sei anni: il risultato fu la creazione di un nuovo polo urbano al di là del fiume Adige, simbolico elemento di separazione tra la “città dei vivi” e la “città dei morti”.
Il cimitero fu costruito in stile neoclassico e nonostante appaia di dimensioni maestose lo spazio disponibile per le sepolture si esaurì in poco tempo. Per questo motivo a partire dal 1910 il camposanto fu ampliato creando una nuova ala di uguali dimensioni sul lato est, il cosiddetto Cimitero Nuovo. Agli anni Trenta del Novecento risale la creazione del tempio-ossario per i Caduti della Grande Guerra e del Cimitero Giardino.

Durante il secondo conflitto mondiale il Cimitero Monumentale di Verona subì ingenti danni a causa dei bombardamenti che colpirono la vicina stazione ferroviaria di Porta Vescovo, tanto che per provvedere alla ricostruzione delle murature crollate e al ripristino delle tombe e delle sculture danneggiate si è impiegato altre un decennio.
Curiosità: la chiesa del cimitero, intitolata al Santissimo Redentore, nel 1884 venne dotata di tre campane alla veronese in tonalità di Sib3.
Cimitero acattolico di Vicenza
 Il cimitero acattolico di Vicenza è un cimitero oramai dismesso della città di Vicenza. Costruito tra il 1830 e il 1833 era destinato a ospitare le salme degli ebrei, dei non cattolici, dei bambini morti senza battesimo e dei militari che servivano l'impero austro-ungarico.
Il cimitero acattolico di Vicenza è un cimitero oramai dismesso della città di Vicenza. Costruito tra il 1830 e il 1833 era destinato a ospitare le salme degli ebrei, dei non cattolici, dei bambini morti senza battesimo e dei militari che servivano l'impero austro-ungarico.
Sull'area presso il fiume Astichello in cui ora sorge il cimitero acattolico, durante il Medioevo era situata l'abbazia di San Vito gestita dai benedettini, nel XII secolo essa fu ceduta ai canonici della cattedrale, nel 1204 divenne sede dello Studio Generale (o Università di Vicenza), ma dopo pochi anni gli universitari se ne andarono e l'abbazia passò ai camaldolesi. Fu demolita nel Cinquecento e i frati si spostarono nel vicino convento di Santa Lucia.
In seguito al decreto italico del 1806 - che aveva vietato la tumulazione nei sagrati o dentro le chiese e aveva imposto di adibire allo scopo un luogo comune e aperto con l'osservanza di determinate prescrizioni - su quest'area fu costruito un cimitero, che avrebbe dovuto servire la città insieme con l'altro costruito poco fuori porta Castello. Quest'ultimo però si dimostrò inadatto dal punto di vista igienico-sanitario, cosicché nel 1817 il Comune decise la costruzione del nuovo cimitero maggiore, i cui lavori nel 1820 erano progrediti a tal punto che vi iniziarono le inumazioni e non fu più usato il cimitero di Santa Lucia.
Si avvertì di nuovo la necessità del cimitero di Santa Lucia alla fine degli anni venti dell'Ottocento, perché l'autorità militare austriaca - a quel tempo Vicenza faceva parte del Regno Lombardo-Veneto - insisteva per tumulare nel nuovo Cimitero anche i soldati, che fino a quel momento venivano sepolti in Campo Marzo. La Congregazione Municipale scelse invece di destinare a questo scopo il vecchio cimitero di Santa Lucia, da qualche anno in disuso. Così tra il 1830 e il 1833 esso venne riadattato su progetto dell'architetto Bartolomeo Malacarne e destinato ad accogliere le salme dei militari e, diviso da un muro in due settori distinti, degli ebrei, dei non cattolici e dei bambini morti senza battesimo. Nel 1879-1880, ormai sotto il Regno d'Italia, il muro all’interno del cimitero di Santa Lucia fu abbattuto e l'unico recinto cimiteriale restò diviso in due parti, l'una per gli ebrei e l'altra per gli acattolici, separate solo da piante. I militari italiani vennero invece tumulati nel Cimitero Maggiore. Durante le due guerre mondiali tuttavia tornarono ad esservi sepolte salme di militari stranieri, specialmente tedeschi.
L'ultima sepoltura risale al 1956. Il cimitero è tuttora aperto al pubblico come spazio verde.
L'ingresso e il recinto, opera del Malacarne, con il loro bugnato rustico di mattoni ricordano quelli del cimitero monumentale, a quel tempo in costruzione.
Risalgono al 1879-1880 la ristrutturazione del portale e la costruzione di due piccoli edifici destinati rispettivamente al custode e alla camera mortuaria, così come la denominazione di cimitero degli Ebrei e degli acattolici.
Cimitero Maggiore di Vicenza
 Il Cimitero Maggiore di Vicenza, già conosciuto come Cimitero Monumentale di Vicenza, è il principale cimitero della città. Costruito dagli architetti Bartolomeo Malacarne e Giacomo Verda tra il 1816 e il 1848 in stile neoclassico, ospita tra gli altri le tombe di Andrea Palladio, Guido Piovene, Mariano Rumor, Virgilio Scapin.
Il Cimitero Maggiore di Vicenza, già conosciuto come Cimitero Monumentale di Vicenza, è il principale cimitero della città. Costruito dagli architetti Bartolomeo Malacarne e Giacomo Verda tra il 1816 e il 1848 in stile neoclassico, ospita tra gli altri le tombe di Andrea Palladio, Guido Piovene, Mariano Rumor, Virgilio Scapin.
Agli inizi dell'Ottocento Vicenza era servita da due cimiteri.
Il primo, costruito verso la fine del XVIII secolo al di fuori delle mura scaligere occidentali (nella zona compresa tra le attuali via Cattaneo, Saudino, Cairoli e Mazzini e vicino al Campo delle esecuzioni di Giustizia), non fu utilizzato a lungo, perché a poca profondità si trovava la falda idrica che creava notevoli problemi igienico sanitari. Pur essendo occupato solo per un terzo, fu soppresso nell'ottobre 1815.
Il secondo era stato costituito in seguito al noto decreto del 1806 - che aveva vietato la tumulazione nei sagrati o dentro alle chiese e aveva imposto di adibire allo scopo un luogo comune e aperto con l'osservanza di determinate prescrizioni - nella coltura dei Santi Vito e Lucia (dov'è ora il Cimitero acattolico) nell'area di un più antico cimitero, il Cimitero di Santa Lucia che, però, da solo era insufficiente ai bisogni della città.
Fu così nominata dal consiglio comunale una commissione di tre cittadini, che dapprima affidò l'incarico di redigere un progetto all'architetto veneziano Giuseppe Jappelli e poi, scartato questo progetto, al vicentino Bartolomeo Malacarne, che lo predispose nel 1815-16, prevedendone la collocazione alla fine di un viale alberato che usciva direttamente da Porta Santa Lucia. Esso fu, invece, spostato più a sud verso la strada postale trevigiana, cioè la strada Postumia - non erano ancora aperte le mura verso Borgo Scroffa – e, iniziato nel 1817, è stato completato nel 1848 sotto la direzione dell'architetto Giacomo Verda.
"Qui il terreno non dà acqua, è di un fondo sabbioniccio ed essendo posto verso nord-est della città combina anche il vantaggio dell'aria": così si esprimeva il Malacarne. A quel tempo la zona era tutta campagna, mentre ora il Cimitero è completamente inglobato nei quartieri urbani.
Mano a mano che i lavori procedevano, cominciavano anche le inumazioni e venivano acquistate le tombe sotto il portico.
Anche questa realizzazione si dimostrò presto insufficiente e in due riprese, nel 1864 e nel 1903, furono costruite delle gallerie coperte sotto i lati nord-ovest e nord-est per portico. Nel 1927 fu deciso un ulteriore ampliamento del cimitero, aggiungendo un'area a nord-ovest che, ulteriormente aumentata nel corso del secolo, ora rappresenta il "cimitero giardino" che alterna, tra gli spazi verdi, colombari di diversa fattura e tombe di famiglia. Dagli anni novanta funziona il nuovo impianto per la cremazione che serve anche i comuni contermini.
Il Cimitero Maggiore consiste in un porticato quadrato di 180 metri per lato e con 127 arcate, in stile neoclassico, che vuol ricordare il portico di una villa palladiana o, meglio, un complesso rurale di ascendenza palladiana. Su ciascuno dei tre lati esso è interrotto da un frontone che racchiude un timpano, a indicare i sepolcri degli illustri e dei benemeriti; sul quarto lato verso viale Trieste è inserita la chiesa.
Il motivo del paramento in laterizio, sagomato a formare il rilievo delle grandi bugne e successivamente scheggiato con lo scalpello ricorre frequentemente nel neo-classicismo locale, come nel Palazzo Franco del Piovene e nel Vescovado del Verda.
All'esterno il porticato è chiuso da un muro a bugnato rustico, in mattoni scalpellati, per quasi tutta la sua altezza. Verso l'interno è costituito da logge aperte sostenute da pilastri anch'essi bugnati. Sotto le volte sono collocate le tombe delle famiglie nobili e possidenti, tra cui quella di Andrea Palladio, realizzata nel 1844 in una cappella a lui dedicata – volutamente collocata sul lato opposto della chiesa, quasi a coronamento del porticato - su progetto dello stesso Malacarne, grazie a un lascito del conte Girolamo Egidio di Velo. Le presunte spoglie di Palladio vi furono solennemente trasferite l'anno successivo, il 19 agosto 1845, dal tempio di Santa Corona. Il monumento funebre fu scolpito dallo scultore di Nove Giuseppe De Fabris.
Al centro del perimetro lo spazio - di nove campi vicentini suddiviso in 13 aree - è occupato dalle tombe interrate di semplici cittadini, con aree specifiche per le religiose e per gli infanti, quasi a riprodurre una società ancora suddivisa in classi. Questa impostazione, cioè il tentativo di riprodurre la città dei morti "perfetta", portò a escludere dal Cimitero Maggiore, nell'Ottocento, coloro che a questa società non appartenevano: ebrei, acattolici e non battezzati. La tumulazione delle loro salme fu invece indirizzata al vicino Cimitero acattolico, insieme con quelle dei militari, nonostante le insistenze dell'autorità austriaca che a quel tempo governava il Lombardo-Veneto.
La chiesa, costruita nel 1920 e dedicata al Cristo risorto, è a pianta circolare ed è sovrastata da una cupola a calotta rotonda ricoperta di rame con lucernario. Un doppio campanile affianca l'abside della chiesa, rivolta verso l'interno del cimitero. Per tutto il Novecento la chiesa è stata officiata e i servizi funebri svolti dai francescani di Santa Lucia che avevano anche la custodia del cimitero.
Cimitero Maggiore di Padova
 Antenorea, odierna Padova, nel lontano 1837, in ottemperanza all’editto di Saint Cloud, vedeva già proliferare idee e progetti attorno alla definizione del Cimitero Maggiore. Le proposte fioccavano, il fermento era tanto. Si partì con il primo progetto presentato dall’ingegnere municipale Giovanni Maestri, un progetto definito valido ma da ridefinire, adattandolo ancor più alle esigenze di culto. L’approvazione giunse finalmente nel 1861 ma, a sorpresa, venne indetto un concorso pubblico. Giunse anche l’anno 1865 e, con gran sollievo, si giunse ad una scelta; la scelta di premiare il progetto di Enrico Holzner, architetto triestino, che con entusiasmo concorreva affianco ad altri ventuno illustri progettisti. Il progetto Holtzner, concepito in «stile lombardo», ben si accordava con le principali architetture di Padova. Solo nel 1881 ottenne approvazione concreta. Nel 1882 furono costruite le mura di cinta, la chiesa con annessa sacrestia e i due portici laterali d’accesso, due edicole interne, due abitazioni di servizio, due edicole agli angoli e la cancellata sul piazzale. Il risultato è un cimitero austero, ordinato, curato ed elegante che ricalca fedelmente il profilo del cimitero monumentale di Milano, ma decisamente in scala ridotta!
Antenorea, odierna Padova, nel lontano 1837, in ottemperanza all’editto di Saint Cloud, vedeva già proliferare idee e progetti attorno alla definizione del Cimitero Maggiore. Le proposte fioccavano, il fermento era tanto. Si partì con il primo progetto presentato dall’ingegnere municipale Giovanni Maestri, un progetto definito valido ma da ridefinire, adattandolo ancor più alle esigenze di culto. L’approvazione giunse finalmente nel 1861 ma, a sorpresa, venne indetto un concorso pubblico. Giunse anche l’anno 1865 e, con gran sollievo, si giunse ad una scelta; la scelta di premiare il progetto di Enrico Holzner, architetto triestino, che con entusiasmo concorreva affianco ad altri ventuno illustri progettisti. Il progetto Holtzner, concepito in «stile lombardo», ben si accordava con le principali architetture di Padova. Solo nel 1881 ottenne approvazione concreta. Nel 1882 furono costruite le mura di cinta, la chiesa con annessa sacrestia e i due portici laterali d’accesso, due edicole interne, due abitazioni di servizio, due edicole agli angoli e la cancellata sul piazzale. Il risultato è un cimitero austero, ordinato, curato ed elegante che ricalca fedelmente il profilo del cimitero monumentale di Milano, ma decisamente in scala ridotta!
Dalla Protezione Civile un'ordinanza sulla funeraria nell'emergenza COVID
Ocdpc n.664 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
18 aprile 2020
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DISPONE
Articolo 1
(Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.
Articolo 2
(Disposizioni in materia di attività cimiteriale)
1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il Prefetto ha facoltà di disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.
Articolo 3
(Trasferimento di risorse sulle contabilità speciali)
1. Le Regioni e Province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalità, giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare.
3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziare, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima Amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837, 66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al Presidente della Regione Lombardia-Soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
Articolo 4
(Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali)
1. In ragione del contesto di criticità di cui in premessa, è facoltà dei singoli Commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli
clic qui per scaricare l'ordinanza







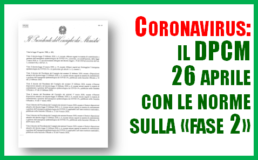


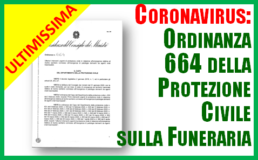
Le Pompe Funebri e la ripartenza
Da alcune settimane questa parola, la ripartenza, di vago sapore austroungarico, è sulla bocca di tutti anche per una sorta di superstizioso augurio dopo la paralisi più lunga che la storia ricordi: dalla fine di febbraio al 3 giugno scorso.
Nella pubblica opinione è maturata la convinzione che il settore funebre sia tra i pochi che non hanno avuto ripercussioni negative da questa pandemia, anzi…, e che gli operatori funebri abbiano avuto buone chance di crescita.
Niente di più sbagliato.
Un certo numero di operatori, è vero, e soprattutto nelle zone rosse, si è trovato a triplicare o quadruplicare il numero dei servizi svolti: si tratta, però e sempre, di servizi effettuati in condizioni di grande precarietà e con condizioni igienico-sanitarie particolari, in totale isolamento oltre che nella fretta e confusione assoluta.
È vero, poi, che nella parte del paese meno coinvolta dalla pandemia, non solo si sono registrati numeri inferiori di servizi, rispetto agli anni passati, ma tali servizi hanno subito le medesime limitazioni subite nelle “zone rosse” a causa delle disposizioni delle autorità sanitarie e dal Governo.
Né si deve dimenticare che analoghe difficoltà hanno interessato tutti i settori “attigui” all’attività funebre: marmisti, operatori cimiteriali, ecc. hanno registrato in questi mesi particolari difficoltà e sono coinvolti da una crisi pesante.
Situazioni, quindi, diverse sicuramente tra le zone epicentro della pandemia ed il resto del paese ma che hanno in comune gli aspetti negativi: tutti gli operatori, a causa delle condizioni sanitarie imposte, non hanno potuto “curare” le famiglie colpite da un lutto con la dovuta attenzione ed i consueti suggerimenti.
I servizi funebri sono stati vissuti più come necessario smaltimento di un “rifiuto infetto” che come un accommiatarsi carico di relazioni. La scomparsa del commiato (“mio padre non l’ho potuto neppure salutare …”), della cerimonia e rito funebre, per non parlare dell’ossequio e della veglia funebre (si pensi alla sostanziale chiusura delle case funebri con i conseguenti gravissimi problemi finanziari stante la recente realizzazione di queste costose strutture) sono la traduzione plastica di questa situazione generalizzata, e subita, in tutto il paese.
Certo, lo abbiamo più volte sottolineato, molti errori nella gestione di questa emergenza, potevano essere evitati; sicuramente la colonna dei camion militari che hanno portato da Bergamo ad altre destinazioni i feretri destinati alla cremazione sono l’emblema di una gravissima sconfitta dello Stato incapace di trovare soluzioni adeguate, anche contingenti, alle necessità.
L’assenza di un soggetto competente su questa materia nei vari livelli della Protezione Civile capace di attivare le procedure necessarie su questi aspetti, come avviene nei paesi cosiddetti civili, porta a questi interventi assolutamente inadeguati ed inappropriati.
Sicuramente nei prossimi mesi avremo la possibilità di una più attenta e istruttiva analisi delle conseguenze sulla corretta elaborazione del lutto determinate da queste scelte, in buona parte obbligate.
Oggi alla categoria si pongono problemi strutturali particolarmente seri e complessi.
Non solo, come si verifica in ogni momento di gravi crisi e di profonde trasformazioni, probabilmente non tutti gli operatori presenti reggeranno a fronte delle trasformazioni del mercato ma per tutta la categoria si pone il problema di superare le défaillances di questa fase e, cosa più complessa, trasformare la crisi in opportunità di trasformazione, rinnovamento e nuovo sviluppo.
La caduta delle “tariffe” di questi servizi ridotti, come si dice, all’osso, la caduta di ogni celebrazione che porta alla standardizzazione massima dei servizi funebri, la spinta alla fretta nell’arrivo a destinazione, il cimitero, e via andando sono elementi che possono minare alla radice i fondamenti delle attività funebri.
Cosa fare? Senza andare alla memoria storica del “che fare” che si poneva Lenin nella “Rivoluzione di ottobre” si apre per la categoria un campo vasto di riflessione anche alla luce degli impegni legislativi da tempo presenti nel Parlamento italiano ed assolutamente necessari per riattivare un processo di unificazione concreta e sostanziale di queste attività sull’intero territorio nazionale.
Qui voglio sottolineare tre elementi.
Prima di tutto oggi molto più del passato si pone la necessità e l’urgenza di investire in professionalità: se la categoria non sviluppa conoscenze e, come dicono i francesi, savoir faire, cioè capacità operativa ed esperienza, sarà arduo recuperare spazi al servizio funebre e salvaguardare questo lavoro dalla semplificazione e standardizzazione assoluta. La formazione professionale vista tradizionalmente dal settore con molte riserve (“a me, con l’esperienza che ho, non si insegna nulla …”) deve, finalmente, diventare un valore assoluto per un imprenditore che vende “servizi” e che ha, come punto di forza il rapporto personale e sempre più profondo con le famiglie.
In secondo luogo, sempre di più si deve puntare sulla qualità dei servizi offerti: il rapporto qualità-prezzo sarà sempre più determinante; l’adeguata qualità dei prodotti offerti, a partire dal cofano, la cura prestata nei servizi, tutti senza eccezione ed in tutti gli aspetti, a partire dall’adeguato abbigliamento, sarà leva indispensabile per il proprio successo.
Terzo elemento, tradizionalmente misconosciuto dal settore se non osteggiato, le necessarie alleanze, qualcuno le chiama partnership; si tratta probabilmente di uno dei più gravi limiti di queste attività, mai superato nel corso degli anni anche se qualche esempio si sta sviluppando: centri servizio, complesse società che si affacciano, …. Il mercato funerario, come è avvenuto per tanti altri settori economici, non si può più affrontare con le singole capacità personali, risorsa preziosa ma inadeguata allo sviluppo di ogni mercato pur settoriale che sia. Il mercato funerario italiano si presenta ancora appetibile e verificherà, probabilmente, una forza di attrazione di capitali attenti alla resa finanziaria. Allora creare alleanze è sempre più importante per non essere fagocitati, o mangiati in un boccone, per parlare semplice. Altri paesi hanno affrontato questi aspetti ed hanno percorso già un bel tratto di strada, basta pensare alle “reti” sviluppatesi in Francia ed in altri paesi europei. Certo oggi non si possono riproporre le esperienze degli anni ‘70 del secolo scorso, cioè la nascita dell’OFISA di Firenze o La Generale di Genova, per citare solo gli esempi più significativi. Allora rappresentavano la tutela rispetto ai processi di frammentazione e polverizzazione presenti sul mercato e la difesa delle imprese presenti, oggi il tema è molto diverso: rafforzare la propria presenza per vincere sulla concorrenza e dare servizi più adeguati alle esigenze del mercato, quindi un guardare decisamente in avanti. Il tema non è quello di “unificare” e “fondere” più imprese, il tema è sviluppare sinergie e trasformarle in sistema solido e duraturo senza perdere la personalizzazione dell’operare. Certo più che allora, quindi, oggi si pone il problema di chi ha le capacità e gli strumenti per guidare la danza e, conseguentemente, la definizione di regole e gerarchie, per queste alleanze, necessarie e sufficienti per vincere la sfida: creare gruppi coesi orientati ed efficienti.
Ci fermiamo qui nella speranza di avere gettato un piccolo seme utile a generare una riflessione ed un confronto sul futuro di un settore ricco di vitalità ma posto, più di altri, di fronte alla necessità di profonde trasformazioni.
Caronte